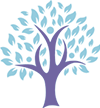La psicologia clinica è una delle principali branche teorico-applicative della psicologia.
Comprende lo studio scientifico e le applicazioni della psicologia in merito alla comprensione, prevenzione ed intervento nelle problematiche psicologiche e relazionali, a livello individuale, famigliare e gruppale, compresa anche la promozione del benessere psicosociale e la gestione (valutativa e di sostegno) di molte forme di psicopatologia.
Assetti centrali della sua pratica sono le applicazioni cliniche delle attività di prevenzione, valutazione, abilitazione-riabilitazione e sostegno psicologico, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla psicodiagnostica ed all’intervento psicoterapeutico, che ne rappresenta un ulteriore sviluppo specialistico rivolto soprattutto alla presa in carico delle situazioni ove è presente una psicopatologia strutturata.
In un senso più ampio, l’operato dello psicologo clinico si rivolge alla prevenzione primaria delle condizioni di disagio personale e relazionale; alla promozione del benessere psicologico e psicosociale; all’identificazione precoce delle problematiche o patologie; al corretto inquadramento dei fattori psicologici, personologici, famigliari, relazionali, ambientali e contestuali che generano e mantengono il disturbo o la difficoltà psicologica; alla gestione clinica, tramite consulenze, colloqui e diverse tecniche di sostegno psicologico, delle principali tipologie di difficoltà personali, famigliari, gruppali e comunitarie; all’abilitazione/riabilitazione nelle problematiche emotive, relazionali, comportamentali o cognitive che fossero non integralmente risolvibili; al sostegno in situazioni di crisi emotiva, relazionale o decisionale del cliente.
Il termine “clinico” non si esaurisce appunto, come erroneamente a volte si ritiene, nella pratica psicoterapeutica. Esso deriva dal greco clinè (letto), e nella prospettiva medica stava ad indicare la cura fornita al capezzale del malato.
L’erronea equivalenza “psicologia clinica = psicoterapia” è probabilmente individuabile nel significato etimologico del termine, associato ad una prospettiva di intervento medico piuttosto che psicologico. Di qui anche l’identificazione di questa disciplina come “psicologia medica”, dizione in realtà impropria. Il termine “clinico” in medicina è diventato sinonimo di intervento terapeutico, e quindi viene riferito alla “patologia”: in psicologia il termine conserva però anche l’originario significato di cura, e viene quindi applicato indipendentemente da un’eventuale patologia del soggetto (ad es., viene applicato anche ad interventi su forme di disagio emotivo-relazionale, anche se tale disagio non si è necessariamente strutturato sotto forma di disturbi psicopatologici nosograficamente specificati).
Esso corrisponde al “prendersi cura di” (to care) piuttosto che al “guarire” (to heal), e quindi è applicato anche nelle situazioni di “normalità”, per facilitare e sostenere il benessere e lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del soggetto. Il doppio significato del termine, nella medicina rispetto alla psicologia, ha dato origine a non pochi equivoci sul ruolo della Psicologia Clinica stessa nelle sue applicazioni. Nelle declaratorie ufficiali italiane delle discipline universitarie, la psicologia clinica è rubricata nel Settore Scientifico Disciplinare (SSD) “M-PSI/08”, stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
In effetti la storia della psicologia clinica è stata segnata dalla diatriba concernente il passaggio dal modello medico al modello psicologico (detto anche a volte “modello biopsicosociale”) di intervento, dato che il primo si era mostrato insufficiente e spesso inappropriato per rispondere a tutte le esigenze di chi richiede una consulenza psicologica.
La psicologia clinica è caratterizzata, altresì, non solo dai suoi possibili ambiti di applicazione, ma anche dall’assunzione di un particolare vertice osservativo, e di una specifica metodologia conoscitiva e d’intervento. In particolare, oltre all’attenzione al dato nomotetico, essa può essere connotata come scienza idiografica, quindi volta anche allo studio di ogni singolo caso nella sua specificità (v. Immagine idiografica).
La cornice epistemologica psicologico-clinica sottolinea:
– La stretta interrelazione individuo-contesto, che rende importante considerare anche la rete relazionale ed ambientale nel quale è inserito il soggetto;
– La centralità della relazione tra clinico e consultante;
– L’importanza di un setting adeguato, co-costruito, che dia la possibilità di attribuire un senso alla relazione;
– Il cambiamento, non più visto esclusivamente come “terapia di una patologia”, ma anche come sviluppo dell’individuo verso modalità simbolico-rappresentazionali, e quindi comportamentali-relazionali, che possano essere più funzionali al suo contesto di vita.
Migliorare la qualità della vita è una prospettiva auspicabile a tutti!
Related Posts
Cos’è la psicoanalisi
La psicoanalisi (da psico-, psiche, anima, più comunemente "mente", e -analisi:...